Mike Flanagan: film e serie TV. Le 6 opere migliori per conoscere il maestro dell’horror contemporaneo
6 titoli che riassumono una carriera già sfavillante
Quando si parla di horror moderno, pochi nomi emergono con la stessa forza di quello di Mike Flanagan. Nato a Salem, nel Massachusetts, città che già nel nome sembra predestinata a legarsi all’occulto, Flanagan ha saputo ritagliarsi negli ultimi dieci anni un posto d’onore tra i registi e showrunner più apprezzati al mondo.
La sua filmografia, a metà strada tra cinema indipendente e grandi produzioni Netflix, è caratterizzata da un marchio stilistico inconfondibile: la paura come veicolo per indagare il dolore umano, il trauma, il senso di colpa e il rapporto con la morte. Flanagan non è interessato al semplice spavento fine a sé stesso. I suoi jump scare – celebri e imitati – sono sempre al servizio della storia, costruiti con una sapienza millimetrica che mescola montaggio, silenzi, e improvvisi ribaltamenti di prospettiva. Ma dietro il brivido, i suoi racconti parlano di famiglie spezzate, di bambini che affrontano l’ignoto, di adulti perseguitati dal passato. La sua è un’arte profondamente emotiva, dove l’orrore non è mai disgiunto dal dramma. Partito dal cinema indipendente, con budget ridotti e tanta inventiva, Flanagan ha trovato la sua consacrazione internazionale con Netflix, trasformandosi in uno dei pochi autori horror capaci di unire il grande pubblico e la critica. Le sue opere non solo spaventano, ma commuovono, invitano a riflettere sulla fragilità dell’esistenza e sulla potenza devastante della memoria. Ecco sei tappe fondamentali per entrare nel suo universo.
Leggi anche The Life of Chuck: recensione del film di Mike Flanagan
1. Oculus – Il riflesso del male (2013) tra i film migliori di Mike Flanagan
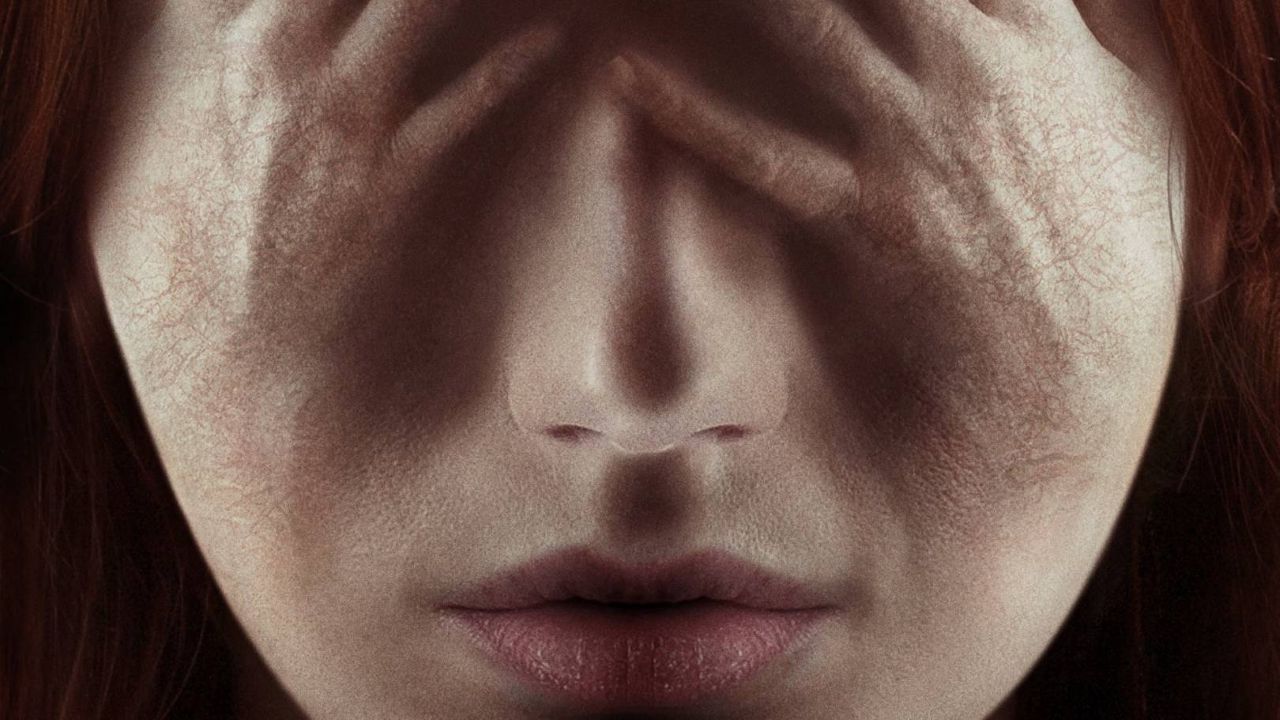
Questo film segna il vero e proprio esordio di Mike Flanagan nel panorama internazionale. Tratto da un suo stesso cortometraggio del 2006, Oculus racconta la storia di due fratelli adulti che cercano di affrontare il trauma vissuto da bambini: un antico specchio maledetto che avrebbe distrutto la loro famiglia. Con un montaggio alternato che intreccia passato e presente, Flanagan costruisce un racconto ipnotico, dove realtà e allucinazione si fondono in modo destabilizzante. Il film rivela già tutte le caratteristiche del suo cinema: l’attenzione per i legami familiari, il trauma infantile che ritorna, la costruzione della tensione più psicologica che spettacolare. Ma soprattutto introduce uno dei suoi tratti distintivi: il modo in cui la paura non nasce solo da ciò che è mostruoso, ma da ciò che è familiare e quotidiano. Oculus fu accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, e dimostrò come Flanagan fosse capace di innovare il genere con idee fresche pur lavorando su un canovaccio classico. È il film che lo proietta a Hollywood, dandogli la possibilità di raccontare storie sempre più ambiziose.
2. Hush – Il terrore del silenzio (2016), film low budget
Girato con un budget ridotto e ambientato quasi interamente in una casa isolata, Hush è uno dei film che meglio mostrano la capacità di Flanagan di costruire tensione con pochissimi elementi. Protagonista è Maddie, una scrittrice sorda che vive in solitudine e che deve difendersi dall’assalto di un misterioso uomo mascherato. L’idea di eliminare quasi del tutto il sonoro e costringere lo spettatore a condividere la condizione della protagonista è un colpo di genio registico: ogni rumore diventa amplificato, ogni silenzio carico di terrore. Flanagan riesce a trasformare un home invasion in un’esperienza immersiva e originale, dove l’orrore si intreccia con la forza e la resilienza di una donna che rifiuta di farsi ridurre a vittima. Interpretato da Kate Siegel, compagna di Flanagan nella vita e sua musa in molte opere, il film è diventato un cult immediato, spesso citato come uno dei thriller più innovativi degli ultimi anni. Non è solo un esercizio di tensione, ma anche un film che riflette sul rapporto tra comunicazione, isolamento e sopravvivenza.
3. Il gioco di Gerald (2017) tra i film Netflix migliori di Mike Flanagan

Adattare Stephen King è sempre una sfida, soprattutto quando si tratta di un romanzo considerato “infilmabile”. Eppure, Flanagan riesce nell’impresa con Il gioco di Gerald, portando su Netflix un thriller psicologico teso e disturbante. La storia di una donna rimasta ammanettata al letto, dopo che il marito muore improvvisamente durante un gioco erotico, diventa un viaggio claustrofobico nei meandri della mente. Carla Gugino, in una delle performance migliori della sua carriera, regge quasi da sola l’intero film, ma è la regia di Flanagan a rendere il racconto così potente: la capacità di rappresentare le allucinazioni, i ricordi traumatici e le proiezioni mentali con uno stile limpido, mai gratuito. La scena della “degloving” (la mano liberata a costo di un’automutilazione estrema) è diventata iconica per la crudezza con cui viene messa in scena, ma l’opera resta memorabile soprattutto per il modo in cui esplora il tema della violenza domestica e dell’abuso infantile. King stesso lodò apertamente il lavoro di Flanagan, consacrandolo come uno dei suoi adattatori preferiti.
Leggi anche Il gioco di Gerald: recensione del film Netflix
4. The Haunting of Hill House (2018) tra le serie TV più famose e amate di Mike Flanagan

Con questa serie Netflix, Flanagan compie il salto definitivo, diventando un autore di culto. The Haunting of Hill House è liberamente ispirata al romanzo di Shirley Jackson, ma si allontana dalla trama originale per costruire un racconto corale sulla famiglia Crain, perseguitata da un passato di fantasmi – reali e interiori. La serie è un capolavoro di scrittura e regia: i fantasmi diventano metafora dei traumi che ognuno dei fratelli si porta dietro, e il racconto alterna orrore soprannaturale a un dramma familiare di rara profondità. L’episodio 6, girato come un unico piano sequenza di quasi un’ora, è un gioiello tecnico che mostra tutta la maestria di Flanagan. Ma più ancora della forma, è il cuore della storia a conquistare: la malinconia di personaggi spezzati, l’idea che la casa stregata non sia solo un luogo fisico ma uno spazio mentale da cui è impossibile fuggire. Hill House è stata salutata come una delle migliori serie horror di sempre, e ha imposto Flanagan come showrunner capace di fondere cinema e televisione con risultati straordinari.
Leggi anche Hill House: la spiegazione della serie tv Neflix
5. Midnight Mass (2021), la serie TV Netflix di Mike Flanagan

Se The Haunting of Hill House aveva fatto conoscere Flanagan al grande pubblico, Midnight Mass rappresenta il suo progetto più personale e intimo. Ambientata in una piccola isola isolata, la serie racconta l’arrivo di un misterioso prete che porta miracoli, guarigioni e, insieme a essi, una maledizione terrificante. Flanagan ha dichiarato più volte che questa è l’opera in cui ha riversato maggiormente se stesso: cresciuto in un ambiente cattolico e poi distaccatosi dalla religione, il regista utilizza l’horror per indagare i dogmi della fede, il fanatismo religioso e il bisogno umano di credere in qualcosa che dia senso al dolore. La serie alterna momenti di puro terrore a lunghi monologhi filosofici, dimostrando una rara ambizione narrativa. Non è un horror per tutti, ma chi vi si immerge trova un racconto di straordinaria potenza emotiva e intellettuale. Con Midnight Mass, Flanagan raggiunge il culmine della sua poetica: il mostruoso come specchio delle nostre domande più profonde.
Leggi anche Midnight Mass: recensione della serie TV
6. La caduta della casa degli Usher (2023)
Con The Fall of the House of Usher, Flanagan rilegge in chiave contemporanea l’opera di Edgar Allan Poe, creando una miniserie che fonde critica sociale, orrore gotico e tragedia familiare. Al centro della vicenda troviamo la potentissima famiglia Usher, magnati della farmaceutica corrotta da segreti, avidità e colpe inconfessabili. Ogni episodio riprende motivi e simboli tratti dai racconti di Poe, ma li rielabora in una narrazione moderna che denuncia gli abusi del potere economico e la decadenza morale dell’élite. La serie è un affresco cupo e sontuoso, dove ogni morte è al tempo stesso metaforica e spettacolare, e dove l’elemento soprannaturale si intreccia con la spietatezza del mondo reale. Flanagan orchestra il tutto con uno stile elegante, mescolando jump scare calibrati, atmosfere gotiche e momenti di intenso dramma umano. Con questa miniserie ha chiuso il suo ciclo con Netflix, lasciando il pubblico con un’opera potente e definitiva, che conferma la sua abilità nel trasformare il classico in qualcosa di radicalmente attuale.
Leggi anche La Caduta della Casa degli Usher: quando Mike Flanagan incontra Edgar Allan Poe